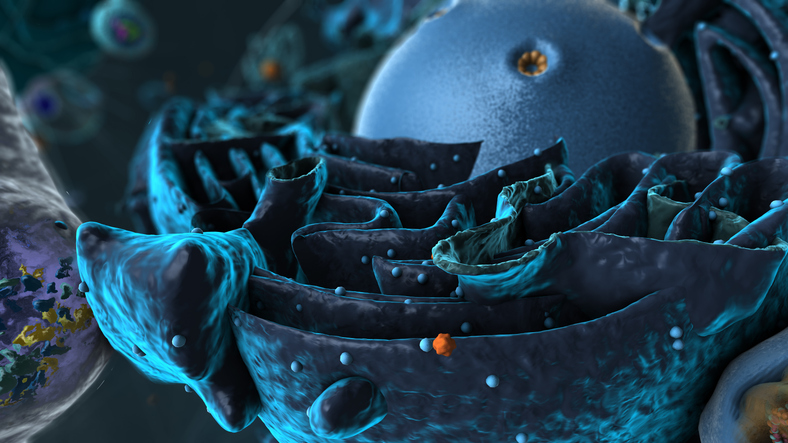Indice
In un’epoca in cui l’aspettativa di vita continua a crescere, non altrettanto si può dire della qualità della vita delle persone che invecchiano. In Italia, sempre più individui raggiungono età avanzate, ma spesso convivono con malattie croniche evitabili, che compromettono la loro autonomia, salute e benessere. Questo fenomeno non è solo una sfida personale, ma ha un impatto collettivo e sistemico: il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si trova ad affrontare costi sempre più ingenti per il trattamento di patologie che, in molti casi, potrebbero essere prevenute. È qui che entra in gioco il concetto di prevenzione primaria e, con esso, il ruolo centrale dell’esercizio fisico.
Ne abbiamo parlato con Francesco Felici, Professore Ordinario di Fisiologia Umana.
Invecchiamento della popolazione e perché serve fare prevenzione primaria
Negli ultimi anni, l’aspettativa di vita in Italia ha continuato ad aumentare. Secondo il Rapporto Annuale ISTAT 2025, nel 2024 la speranza di vita alla nascita ha raggiunto 83,4 anni. In particolare, si parla in media di: 81,4 anni per gli uomini e 85,5 anni per le donne. Questo importante traguardo demografico conferma il primato dell’Italia tra i Paesi più longevi d’Europa.
Tuttavia, non sempre a questa longevità corrisponde una buona qualità della vita negli anni avanzati. Anzi l’incremento della vita media non è andato di pari passo con quello anni vissuti in buona salute. Questo fenomeno ha generato un ampliamento della fase della vita in cui molte persone convivono con malattie croniche, disabilità o limitazioni cognitive e funzionali che riducono l’autonomia e il benessere quotidiano.
Più nello specifico, il divario tra gli anni vissuti e quelli vissuti in buona salute è significativo. Secondo gli stessi dati ISTAT, nel 2024 un uomo vive in media 59,8 anni in buona salute, mentre una donna 56,6 anni. Questo significa che per oltre 20 anni della propria vita si rischia di convivere con problemi.
È proprio in questa finestra di vulnerabilità che la prevenzione primaria diventa importante. Questo tipo di prevenzione mira a evitare l’insorgenza di malattie attraverso la promozione di stili di vita sani, tra cui l’attività fisica regolare, l’alimentazione equilibrata e l’astensione da fumo e alcol.
Decessi evitabili
Il bisogno di intervenire precocemente è evidenziato da un altro dato chiave. Sempre secondo ISTAT ogni anno, in Italia, si registrano circa 90.000 decessi evitabili sotto i 75 anni.
“Si tratta di vite che potrebbero essere salvate attraverso politiche sanitarie efficaci, diagnosi tempestive e, soprattutto, interventi di prevenzione primaria. La cosiddetta “mortalità evitabile” comprende sia quella trattabile (con cure mediche adeguate), sia quella prevenibile (riducibile agendo sui fattori di rischio)” spiega Felici.
In un Paese come l’Italia, che dispone di un Servizio Sanitario Nazionale pubblico, investire in prevenzione non è solo una scelta sanitaria ma anche economica. Significa, in pratica, ridurre la pressione sulla sanità, oltre che migliorare la qualità della vita e aumentare gli anni vissuti in buona salute.
“Per questo, investire nella prevenzione primaria significa non solo salvaguardare la salute dei cittadini, ma anche garantire la sostenibilità del sistema sanitario nel tempo. E in questo scenario, l’esercizio fisico rappresenta uno degli strumenti più efficaci e accessibili per agire in anticipo sul rischio di malattia. Dico accessibili perché basterebbe che le istituzioni organizzassero e facilitassero l’arrivo delle persone anziane in spazi per attività fisica di varia natura, incluso, per esempio, il ballo” sottolinea Felici.
Perché serve restare attivi e quanto prevenzione primaria facciamo?
In tutti i dati riportati è evidente che l’invecchiamento della popolazione, se non accompagnato da interventi di prevenzione efficaci, rischia di tradursi in una progressiva riduzione della qualità della vita, del benessere fisico e dell’autonomia degli individui e in una crescente dipendenza da sistemi di assistenza di sempre più persone.
È in questo scenario che si inserisce l’importanza dell’attività fisica regolare, uno dei pilastri della prevenzione primaria. Mantenersi attivi significa preservare nel tempo ciò che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come abilità funzionale: la capacità di compiere azioni quotidiane in modo autonomo e sicuro. “Questa abilità non è statica, ma può essere allenata e migliorata, anche in età avanzata” ricorda Felici.
Purtroppo però, l’Istituto Superiore di Sanità dice che tra gli over 65 soltanto il 40 % svolge il livello minimo di esercizio consigliato. Ben il 38 % è completamente sedentario.
Capacità intrinseca e allenamento
L’invecchiamento in salute (Healthy Ageing) è definito come il processo tramite il quale sviluppiamo e manteniamo l’abilità funzionale che ci permette di vivere in buona salute nell’età anziana.
“Questa abilità – afferma Felici – non dipende soltanto dalle caratteristiche biologiche individuali, ma è il risultato dell’interazione tra la persona e l’ambiente in cui vive. Tale interazione modella nel tempo sia le sue capacità intrinseche (come forza, equilibrio, resistenza), sia la sua abilità funzionale (ovvero ciò che riesce concretamente a fare nella vita quotidiana)”.
Una traiettoria ottimale è quella di chi riesce a vivere a lungo mantenendo un’elevata capacità intrinseca per tutta la vita. Ma anche una traiettoria non ottimale può essere migliorata. L’allenamento di forza, per esempio, può aiutare un soggetto fragile a recuperare parte delle proprie capacità fisiche, restituendogli autonomia e benessere.
Allenamento della velocità
Nelle persone anziane è stato dimostrato che programmi mirati di esercizio fisico, in particolare quelli che includono l’allenamento della forza e della velocità, sono efficaci nel contrastare la perdita di potenza muscolare.
Per capire il valore di questo tipo di allenamento, è utile ricordare che la potenza muscolare è data dalla combinazione di forza (la capacità di esprimere una tensione muscolare) e velocità (la rapidità con cui quella forza viene applicata).
Con l’avanzare dell’età, non solo la forza muscolare diminuisce, ma a calare ancora più rapidamente è proprio la velocità di contrazione muscolare. Questo significa che, anche se una persona mantiene un certo livello di forza, rischia comunque di perdere la capacità di reagire in modo rapido, per esempio per evitare una caduta, perché i suoi muscoli non si attivano abbastanza in fretta.
Inoltre, anche il sistema nervoso centrale diventa meno efficiente: con l’età, tende a perdere la capacità di “accendere” rapidamente le fibre muscolari necessarie per un’azione veloce ed esplosiva.
È qui che entrano in gioco gli allenamenti a velocità elevata, noti come VBT – Velocity-Based Training. Questi protocolli sono pensati per stimolare sia il muscolo che il sistema nervoso. Migliorano la capacità del corpo di esprimere forza rapidamente, cioè di aumentare la potenza. E i risultati si osservano anche in soggetti fragili, anziani o con mobilità ridotta. Questi, infatti, spesso riescono a recuperare funzionalità e autonomia grazie a questi programmi.
La necessità di competenze specifiche
Allenarsi non serve solo a “mantenersi in forma”, ma può fare la differenza tra essere autonomi o dipendenti, tra vivere attivamente o ritirarsi dalla vita sociale. In un Paese che sta rapidamente invecchiando, restare attivi è una scelta individuale che ha un impatto collettivo. Contribuisce a ridurre il carico sulla sanità pubblica, a prevenire le disabilità e ad aumentare gli anni vissuti in buona salute.
“Per raggiungere questo obiettivo – conclude Felici – è fondamentale curare la formazione di figure preparate e competenti nel suggerire il programma di allenamento. Competenza e preparazione che devono coprire anche, forse soprattutto, la crescente domanda di esercizio fisico da parte di persone con patologie croniche, dal diabete al neurologico al fisiatrico e l’elenco è sicuramente più lungo di così. Naturalmente, non si pretende di eliminare la patologia, ma certamente se ne può attenuare/rallentare il decorso e la gravità dei sintomi, riuscendo, eventualmente, anche a contenere l’impatto delle terapie farmacologiche“.