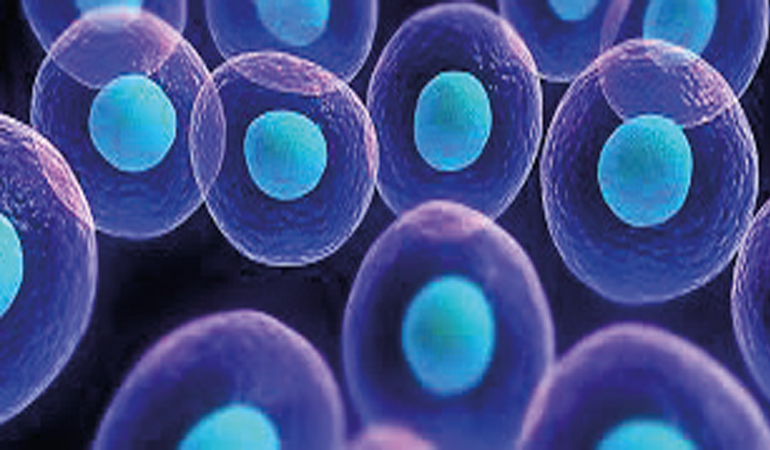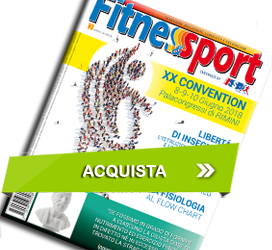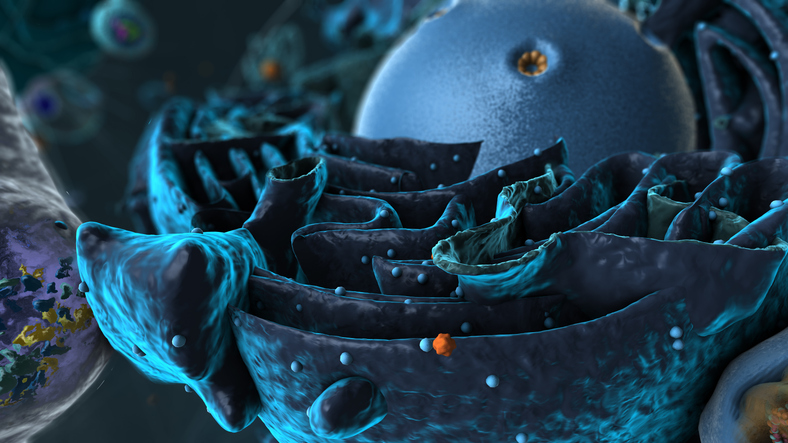Indice
La ritenzione idrica è un sintomo molto comune, spesso sottovalutato, che può nascondere squilibri ben più complessi. I problemi possono riguardare: infiammazione cronica, alterazioni ormonali o cattive abitudini alimentari. Ma come combattere davvero la ritenzione idrica, evitando soluzioni superficiali e temporanee?
Personalmente credo che qualsiasi test o valutazione debba essere affiancato all’osservazione oltre che a una conoscenza reciproca. Ho perciò utilizzato la fisiologia applicata usando un bioimpedenziometro che rilevasse con precisione e ripetibilità l’acqua extracellulare ECW e la massa magra rapportata all’altezza FFM/H (dove vi è una costante, l’altezza, rapportata a una variabile, la FFM). Inoltre, ho misurate circonferenze e pliche distrettuali (plicometria) e presa visione reale e fotografica nel tempo. Questo perché la massa magra è una stima globale, così come lo è l’acqua extracellulare (ECW).
Se guadagno o perdo massa magra o ECW in un distretto lo posso sapere solo e soltanto se abbino circonferenze e pliche combinate tra loro. Le fotografie fanno poi il resto.
Capire come e perché tratteniamo liquidi, dove e in quali condizioni, è il primo passo per agire in modo efficace e duraturo.
Cos’è la ritenzione idrica e cause di questo problema
La ritenzione idrica è una risposta a un’infiammazione acuta, sub acuta o cronica data spesso da stress, alimentazione errata, allenamento eccessivo, problemi ormonali, linfatici e cardiocircolatori, oltre a rigidità e postura sbagliata.
L’infiammazione è un meccanismo di difesa aspecifico, che costituisce una risposta protettiva, seguente all’azione dannosa di agenti fisici, chimici e biologici, il cui obiettivo finale è l’eliminazione della causa iniziale di danno cellulare o tissutale.
Effetti e sintomi della ritenzione idrica
I tipici effetti a livello sistemico sono:
- perdita di massa muscolo scheletrica,
- stanchezza cronica (proteolisi muscolare), alterazioni dell’equilibrio idrico (TBW),
- mancanza di sistemi tampone, variazione della termoregolazione, alterazioni metaboliche, tipici di un forte catabolismo proteico;
- aumento della sintesi epatica proteica (proteina C reattiva).
Dal punto di vista idro-elettrolitico l’aumento dell’acqua extracellulare (ECW) corrisponde a perdita dell’acqua intracellulare (ICW) con relativa alterazione degli elettroliti e conseguente variazione del potenziale di membrana cellulare.
Se l’infiammazione è cronicizzata, l’edema aumenta ulteriormente con ulteriore ristagno dei liquidi nei tessuti per aumento della pressione osmotica del tessuto interstiziale che aumenta l’ECW ulteriormente.
L’acidità extracellulare aumenta per il ristagno e per l’incremento dell’attività catabolica (soprattutto quella muscolare) che va ad accentuare la glicogenolisi (scissione del glicogeno in glucosio). Aumenta così sia la concentrazione di proteine nell’ambiente extracellulare, (dal 2,5% al 10%) sia la concentrazione di acidi organici (acido lattico, ialuronico, acidi nucleici e acidi grassi). I valori del pH extracellulare in caso d’infiammazione cronica sono vicini o inferiori a sei e questo varia e modula il potenziale di membrana cellulare.
La fisiologia della ritenzione idrica, capire cosa succede per sapere come combattere il problema
Il cambiamento del pH nel citoplasma e nell’ambiente extracellulare è associato a molte condizioni fisiologiche e patologiche come esercizio intenso e ipossia. Esso influisce sulla sintesi proteica, a crescita e proliferazione, controllate anche dal mTORC1. mTOR (acronimo di mammalian target of rapamycina) è una protein-chinasi che fosforila serina e treonina e che regola la crescita, la proliferazione, la motilità e la sopravvivenza delle cellule, la sintesi proteica e la trascrizione.
Cellule esposte a pH 6.2–6.6 hanno evidenziato una diminuzione rapida e pronunciata della segnalazione di mTORC1 rilevata dopo 5’ e completa in 30’. Un’elevata attività mTORC1 è stata osservata a valori fisiologici di pH 7.2–7.4. Bassi livelli di pH possono influenzare negativamente la sintesi proteica.

La modulazione ha anche un ruolo preciso nella regolazione del volume della cellula che mantiene sotto controllo la concentrazione dei soluti all’interno della stessa. Si regolano così le forze osmotiche che possono far aumentare o diminuire i volumi delle cellule (ECW/ICW).
In condizione d’infiammazione cronica con alterazioni idroelettrolitiche dell’ambiente extracellulare (aumento dell’ECW), il potenziale di membrana cellulare cambia lentamente diminuendo i propri valori di riposo (inferiore al -70mV con tendenza verso lo 0).
Le conseguenze sono perciò la diminuzione del potenziale di soglia, la riduzione della frequenza dei potenziali d’azione oltre che la diminuzione netta della capacità regolativa idroelettrolitica sia locale sia sistemica con ridotte attività funzionali, riparative o conservative. L’importanza del ripristino del potenziale di membrana a riposo e quindi della normo condizione idroelettrolitica è necessaria per uscire dalla condizione di omeostasi cronica. Il potenziale d’azione è il potenziale di membrana che ha una cellula quando è “eccitata” attraverso la conduzione di stimoli. Un potenziale d’azione è, di fatto, una fluttuazione elettrica che viaggia lungo la superficie della membrana di una cellula.
Come combattere la ritenzione idrica: un approccio integrato
La ritenzione idrica è un fenomeno multifattoriale che non può essere ridotto a una semplice questione estetica o circoscritta all’assunzione di sodio. Per affrontare in modo efficace la ritenzione idrica è necessario un approccio integrato, che tenga conto dei segnali biochimici, dell’equilibrio idroelettrolitico, della qualità della massa magra, della funzione linfatica e dell’omeostasi acido-base. In particolare, la distribuzione dell’acqua tra compartimenti intracellulare (ICW) ed extracellulare (ECW) costituisce un indicatore chiave dello stato di benessere tissutale e della vitalità cellulare.
Contrastare la ritenzione idrica non significa semplicemente drenare liquidi. Vuol dire: ristabilire una condizione di equilibrio, ripristinando il corretto potenziale di membrana, la funzionalità dei trasportatori ionici, la risposta infiammatoria e la capacità del muscolo scheletrico di trattenere glicogeno e acqua all’interno della cellula.
In tal senso, l’intervento deve agire su più fronti: nutrizione personalizzata, modulazione dell’allenamento, gestione dello stress, supporto posturale e valutazione bioimpedenziometrica.
Le strategie che seguono derivano dalla fisiologia applicata e da un’osservazione clinica sistematica, con l’obiettivo di proporre un modello di intervento tanto rigoroso quanto efficace.
Si arriverà in conclusione a determinare varie strategie di azione in base alle singole peculiarità degli individui.
Potenziale d’azione e omeostasi elettrica della cellula
Per comprendere perché alcune strategie funzionano, è utile capire cosa succede nella cellula quando viene alterato il potenziale di membrana. Le fasi di un potenziale d’azione possono essere così descritte.
- Uno stimolo adeguato provoca l’apertura di alcuni canali per il sodio; il sodio entra nella cellula e s’instaura una depolarizzazione parziale
- Se il valore della depolarizzazione raggiunge o supera il “potenziale di soglia”, (circa 15 mV in meno rispetto al potenziale di riposo) sono indotti all’apertura molti canali per il sodio detti voltaggio-modulati. I canali voltaggio-modulati si aprono in seguito a variazioni della differenza di potenziale della cellula. Il potenziale di soglia è il valore minimo per avere apertura di tali canali. Se non si raggiunge il valore soglia molti canali per il sodio voltaggio-modulati restano chiusi, e non si genera un potenziale d’azione.
- L’entrata di sodio provoca diminuzione del potenziale di membrana della cellula, che assume valori sempre più positivi fino a circa + 30 mV.
- I canali voltaggio-modulati rimangono aperti per circa 1 millisecondo per poi richiudersi consentendo al sodio di entrare per periodi sempre uguali inducendo valori di differenza di potenziale simili. Il potenziale d’azione è una risposta del tipo “acceso o spento”. Se non si raggiunge il potenziale soglia non si genera alcun potenziale d’azione. Se si supera il valore soglia il valore della differenza di potenziale raggiunge sempre il valore massimo di circa +30mV.
- Raggiunto il potenziale d’azione, dopo che si sono richiusi i canali del sodio voltaggio-modulati, si è raggiunto il potenziale di riposo e in tal modo può fuoriuscire un ulteriore quantitativo di potassio che porta la cellula, per un breve periodo di tempo, in condizione d’iperpolarizzazione con valori pari a -100/120 mV.
- L’azione della pompa sodio-potassio e la chiusura di tutti i canali voltaggio-modulanti riporta il potenziale di membrana a valori di normalità (-70/90 mV).

Cosa succede in pratica…
Riassumendo, in una cellula a riposo rimangono aperti molti canali per il potassio, mentre per il sodio sono chiusi. Gli ioni potassio che si trovano dentro la cellula possono quindi diffondere con facilità all’esterno ma le cariche negative dei grandi anioni proteici li richiamano fortemente all’interno. Essi, infatti, permangono all’interno della cellula perché non possono uscire per la loro grande dimensione.

Essi rientrano quindi facilmente perché la maggior parte dei loro canali sono aperti. Gli ioni sodio, al contrario, rimangono sulla superficie esterna della membrana perché, pur essendo presente un gradiente elettrico e chimico favorevole all’entrata, la maggior parte dei loro canali sono chiusi.
All’interno della cellula permane quindi una maggior quantità di cariche negative perché gli ioni potassio non bastano a equilibrare gli anioni. Le caratteristiche della membrana ripartiscono quindi gli ioni potassio e sodio in questa modalità, ma per mantenere il potenziale di riposo si attiva anche il meccanismo della pompa sodio-potassio che trasporta tre ioni sodio al di fuori della cellula e due ioni potassio all’interno. Questa modulazione di cariche provoca un continuo squilibrio elettrico attraverso la membrana contribuendo al mantenimento della differenza di potenziale di membrana a riposo.
… e le condizioni di normalità e anormalità
In condizioni di normalità abbiamo una situazione dove la distribuzione qualitativa della massa magra (FFM) avrà una massa intracellulare (BCM) maggiore di quella extracellulare (ECM). Conseguentemente l’acqua intracellulare (ICW), marker dell’energia cellulare e il potassio (K) saranno in quantità ottimale.
La quantità di ECM in equilibrio, consentirà una “corretta” quantità di sodio extracellulare (Na) e non vi saranno infiammazioni (ECW) o ritenzione idrica.
In condizioni di anormalità abbiamo invece una situazione dove la distribuzione qualitativa della massa magra (FFM) avrà una massa intracellulare (BCM) inferiore di quella extracellulare (ECM). Conseguentemente l’acqua intracellulare (ICW) e il potassio (K) non saranno in quantità ottimali con relative alterazioni del potenziale di membrana. Maggiore ECM è uguale a eccesso di sodio nell’ambiente extracellulare con relative infiammazioni o alta ritenzione idrica. Un basilare indice di benessere dipende dalla corretta distribuzione dell’acqua totale nei due compartimenti.
Cosa fare per combattere la ritenzione idrica a seconda della composizione corporea
Per capire come combattere la ritenzione idrica, non è tanto importante sapere che il nostro corpo contenga per esempio 50 Lt di acqua, quanto la sua distribuzione. Molti studi confermano che la normoidratazione è presente solo nei soggetti sani e ben nutriti.
La maggior parte del liquido perso con il sudore proviene dal comparto extracellulare, in particolare dal plasma. Quasi nella totalità dei casi le variazioni dell’acqua corporea avvengono in questo compartimento, mentre le variazioni in più o in meno del compartimento intracellulare sono nell’ordine di + o – 5 %.
Una variazione superiore potrebbe causare danni alla massa cellulare stessa. Nei liquidi corporei sono presenti dei soluti ed è importante comprendere che alcuni di questi sono prevalentemente Intra o Extracellulari.
Vi sono diversi fattori che possono alterare il rapporto della distribuzione idrica nel corpo umano. Come anticipato, situazioni come infiammazioni croniche, squilibri ormonali e infezioni possono aumentare i processi catabolici che portano al versamento dei fluidi intracellulari nell’ambiente extracellulare (in seguito alla rottura della membrana cellulare).
I nostri muscoli contengono circa 18 g di glicogeno da stoccare per ogni Kg di muscolo. Ogni grammo di glicogeno trattiene da 2.7 a 3.3 g di acqua. La possibilità di stoccare il glicogeno avviene nel fegato, circa un terzo se sano, e i due terzi nei muscoli. Più muscoli, più possibilità di immagazzinare il glicogeno proveniente dall’alimentazione.
Schema flow chart per stabilire percentuali di proteine e grassi e quale allenamento
A questo punto, di seguito, lo schema Flow Chart che tiene in considerazione FFM/H e ECW al fine di poter stabilire le percentuali tra carboidrati proteine e grassi oltre che l’allenamento.
Nelle seguenti tabelle è possibile verificare, in base alla propria composizione corporea, come agire per combattere con successo la ritenzione idrica. Le leve su cui agire sono le strategie alimentari e d’allenamento.
Desideri leggere tutti gli articoli presenti nella rivista e riceverne una copia cartacea a casa?
Se sei un nuovo utente, REGISTRATI sul sito e acquista l’Abbonamento!
oppure
Se sei già un utente registrato, EFFETTUA IL LOGIN e rinnova il tuo Abbonamento alla Rivista!
Inoltre, una volta che ti sarai REGISTRATO, avrai la possibilità di partecipare alla CONVENTION ISSA e Iscriverti ai nostri CORSI e SEMINARI!